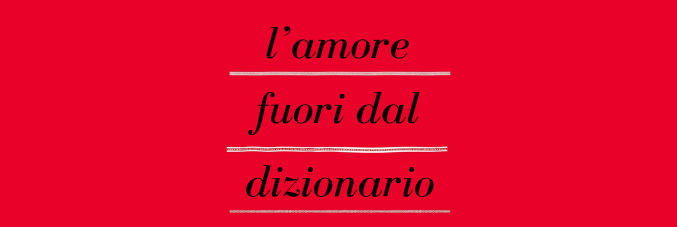
L’AMORE FUORI DAL DIZIONARIO. A partire da All About Love di bell hooks: tutto quello che (non) ci aspettavamo sull’amore
di Next Generation CEC
(redazione a cura di Giovanna Miolli, Giulia La Rocca, Clara Mogno, Amelia Vietri)
Abbiamo deciso di leggere insieme il libro All About Love (1) di bell hooks perché il titolo ci sembrava promettente: ci avrebbe aiutate a fare un po’ di chiarezza. Ci interessava il rapporto tra violenza di genere e rappresentazioni (distorte?) dell’amore che spesso sono usate come forme di giustificazione e legittimazione dell’abuso. Volevamo sapere, insomma, che cosa aveva scritto bell hooks, per smentire quelle rappresentazioni.
Ebbene, le nostre aspettative hanno subito un contraccolpo. Perché? Non lo abbiamo capito immediatamente, ma con il passare degli incontri di discussione ci siamo rese conto che stavamo presupponendo una certa bell hooks. Credevamo di incontrare la docente femminista e antirazzista che, pur sviluppando un approccio critico al mondo accademico, si inseriva comunque in questo ambito.
Stavolta, invece, navigavamo in un testo che mescolava (senza pretese dimostrative, ma certamente persuasive) numerosi riferimenti all’esperienza personale, citazioni copiose ma non “stringenti”, e uno stile discorsivo simile al sermone, un genere molto diffuso negli Stati Uniti come modalità comunicativa.
Nei primi incontri, alcune di noi quasi “protestavano”: in All About Love ci sembrava mancare quel tipo di argomentazione e concatenazione logica di cui ci eravamo nutrite con sollievo (perché capire le cose, libera) in occasione di altri suoi testi.
Forse, però, stavamo sbagliando. Ce lo siamo chieste verso la fine del secondo incontro e siamo ripartite da lì al terzo incontro. Forse eravamo noi a non lasciare che il testo fosse ciò per cui era stato concepito.
Cominciamo allora dall’idea principale del libro. bell hooks sostiene che ha deciso di scriverlo in risposta alla sfiducia nei confronti dell’amore, che lei percepisce come fenomeno diffuso in vari strati e ambiti della società. «Ogni cosa intorno a me» dice «sembrava testimoniare che l’assenza d’amore era all’ordine del giorno» (p. 6).
Ma che cos’è l’amore? La causa principale di tanti fraintendimenti, afferma bell hooks, è che manca una (buona) definizione. O meglio, il problema è che molte azioni concepite come espressioni di amore derivano da definizioni parziali dell’amore stesso. Cioè da una grande confusione.
«La confusione sul significato da dare alla parola “amore” è all’origine della difficoltà di amare» (p. 21). È una tesi forte, questa. Ci sta dicendo che parte dell’abilità di amare “bene” c’entra con il sapere, il conoscere, con il fare chiarezza. L’amore non è un mero sentimento. È anche un progetto conoscitivo. Dobbiamo interrogarci, formulare (auto)critiche, esplorare al di là di quello che ci sembra scontato.
La ricerca parte dal porre sotto esame la definizione che sembra essere la più diffusa: quella reperibile nei dizionari. Questi «tendono a enfatizzare l’amore romantico, descrivendolo in primo luogo come “affetto profondo, tenero e appassionato, basato principalmente sull’attrazione sessuale”» (p. 21). bell hooks non è soddisfatta da questa proposta. Racconta di aver cercato a lungo e letto tanto prima di imbattersi nella definizione offerta da Morgan Scott Peck nel manuale di auto-aiuto The Road Less Traveled (1978; trad. it. Voglia di bene): «l’autore definisce l’amore come “volontà di estendere il proprio sé al fine di favorire la crescita spirituale propria o di un’altra persona”. E prosegue: “L’amore […] è un atto di volontà; più precisamente è al contempo un’intenzione e un’azione. La volontà implica anche una scelta. Non siamo costretti ad amare. Scegliamo di farlo”» (p. 22).
È partendo da qui che bell hooks costruisce il libro All About Love. In ogni capitolo esplora aspetti e sfumature diverse dell’amore che si generano dalla comprensione profonda di questa definizione.
Vi proponiamo alcuni punti della prospettiva offerta da bell hooks: cose che ci sono piaciute e questioni che abbiamo accolto come sfida perché non sempre in accordo con le nostre interpretazioni. Lo scopo dell’autrice con questo libro era evidenziare i «rischi» della disillusione personale e collettiva nei confronti dell’amore e «lanciare un appello in favore di un ritorno» a esso (p. 6). Il nostro scopo è continuare questo processo di “complessificazione” dell’amore, dove emerga con forza che si tratta, come dicevamo, di un progetto pratico e conoscitivo, che passa anche per la critica sociale e la messa in questione delle definizioni.
Seguiremo una scrittura “a mosaico”, condividendo delle riflessioni su alcuni temi legati al libro.
Una definizione generativa, che vuole fare chiarezza
Dopo aver ricalibrato il significato di amore in base alla nuova prospettiva ispirata da Morgan Scott Peck, bell hooks può spaziare in un vasto campo: improvvisamente questo concetto significa e “fa” molte (più) cose. La fuoriuscita dal solo ambito della relazione sentimentale, tema comunque approfondito in tutto il libro, permette all’autrice di sviluppare un discorso che intercetta numerose aree in cui l’amore sarebbe operante: la spiritualità, il lavoro, la cura di sé, la giustizia, la sincerità e l’onestà, l’etica, la comunione di affetti, l’amicizia e la reciprocità, il lutto, la guarigione, il destino. La varietà dei contesti, esaminati secondo un ordine non necessariamente consequenziale, ci ha portate a intendere questo scritto come un puzzle. Ogni capitolo è un frammento che si aggiunge a una nuova vista caleidoscopica sull’amore.
C’è un “però”. L’amore inizia a significare un po’ troppe cose, tanto che a un certo punto sembra che questa varietà (o equivocità) si ritorca contro quello che l’autrice stessa desidera offrire: una definizione chiara, che aiuti l’azione quotidiana. Se cominciamo a chiamare tanti aspetti e situazioni con lo stesso nome, non rischiamo di perdere le differenze? Non finiamo per annullarle dentro un calderone in cui “tutto fa brodo”?
Di fronte a questa domanda, abbiamo riconsiderato il titolo dell’opera: All About Love. Ci serviva affinare l’interpretazione per capire quali direzioni prendere. Se ne presentavano almeno due. La prima era abbracciare una visione simile: questo libro contiene tutto quello che si può dire sull’amore come oggetto di trattazione, tutti gli aspetti che lo caratterizzano. Il secondo cammino, che meglio rispecchiava ciò che stavamo sperimentando nella lettura, era invece comprendere il titolo come se fosse stato It’s All About Love: tutto ha a che fare con l’amore. È tutta una questione d’amore. In questo secondo caso, il concetto di amore diventa il legante delle varie scene presentate dal libro e sposta l’asse semantico da “relazione amorosa” a “relazione d’amore”, che può essere praticata in ogni circostanza.
Torniamo allora alla “definizione minima” che ci ha trasmesso l’autrice: la «volontà di estendere il proprio sé al fine di favorire la crescita spirituale propria o di un’altra persona». Chiarezza, non significa “chiusura”. bell hooks vuole darci una definizione chiara, ma al tempo stessa aperta, capace di creare nuove situazioni e relazioni all’insegna di questo principio: desiderare la propria crescita e quella delle altre persone. È una definizione operativa, non fotografa uno status, ma propone un modo di agire.
Partendo da questo nucleo generativo, bell hooks intende decostruire una narrazione sull’amore come sentimento e/o passione “a due” per mostrarcelo come fenomeno sociale, condiviso e complesso. Complesso proprio perché coinvolge contemporaneamente diverse componenti che si rapportano e co-determinano.
Pensando all’occasione in cui questo nostro testo collettivo viene pubblicato per la prima volta – la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – è importante insistere su un punto. Nella prospettiva di bell hooks, ci sono alcuni elementi che questa definizione di base squalifica, cioè che reputa inammissibili. «Si può ritrovare l’amore solo se si abbandona l’ossessione del potere e del dominio sugli altri» (p. 75). In questo come in numerosi passaggi del libro, l’autrice è molto netta, perimetra delle aree in cui esclude categoricamente che possa esserci amore se riconosce che prevalgono altri aspetti: la menzogna, la mancanza di trasparenza, il dominio, il potere, il controllo, la dipendenza.
Questa linea di demarcazione così rigida, se in alcuni casi è utile e condivisibile, in altri è problematica. Lo è perché non sembra ammettere una “teoria della gradualità” dell’amore, ma tratta quest’ultimo come un blocco uniforme che c’è o non c’è, viene praticato o non viene praticato. Soprattutto nel caso della/e dipendenza/e ci è parso che sarebbe stato necessario un approccio capace di differenziare in modo più raffinato diverse casistiche possibili, considerando le vulnerabilità di ciascunə così come le storie personali, le condizioni materiali di partenza e la disponibilità dell’intorno ad aiutare.
Ciononostante, come si diceva, la divisione proposta ha il vantaggio di chiarire i possibili fattori che “mettono a rischio” l’amore o lo rendono impossibile. Tra questi ci sono la violenza, il controllo, la manipolazione. Per bell hooks si tratta di negare radicalmente l’idea che amore e maltrattamenti possano stare nella stessa casella, piuttosto, «maltrattamenti e disinteresse negano e distruggono l’amore» (p. 33). Qui l’autrice ha in mente sia la relazione genitori-figli sia le relazioni sentimentali.
Gli abusi e le coercizioni non per forza devono essere eclatanti, anzi, bell hooks denuncia forme di non comunicazione e sottrazione. In uno slogan potremmo dire: l’amore può anche sembrare un mistero, ma non fa il misterioso. In altre parole, la persona che dice di amare, non si nega al dialogo e alla conoscenza dell’altrə. Questo è un punto a dir poco decisivo per smascherare le forme di micro-abuso e induzione a far sentire l’altrə inadeguatə che vengono inflitte sotto la falsa scusa di mantenere vivo l’amore. Scrive bell hooks: «È importante considerare la conoscenza un elemento essenziale dell’amore, perché tutti i giorni siamo bombardati da messaggi che ci dicono che l’amore ha una forte componente di mistero, che è per sua natura inconoscibile. […] Il messaggio che ci arriva […] è che la conoscenza rende l’amore meno irresistibile; che è l’ignoranza a conferire all’amore la sua forza erotica e trasgressiva» (pp. 80-81).
“Restare misteriosi” è una via per la manipolazione. Il suo antidoto sono il dialogo, il confronto, una riflessione critica sempre attiva. Ciò che l’autrice condensa nell’espressione «un’etica d’amore» (p. 81).
C’è un altro aspetto della prospettiva di bell hooks, già menzionato sopra, che vale la pena rimarcare e che può servire da base per una critica alla violenza. Considerare l’amore come fenomeno sociale (e non solo individuale o duale) ci permette di comprenderlo anche come questione politica, cioè che riguarda il modo in cui costruiamo relazioni all’interno di una comunità. Perché questo passaggio di piano è importante? Perché continuare a credere che l’amore sia solo una faccenda individuale e legata all’imprevedibilità dei sentimenti (che ci “capita” di provare) ci toglie capacità d’azione. Ci induce a pensare che sia affare di ognunə risolvere il proprio problema amoroso. Al contrario, riconoscere l’amore come fenomeno sociale estende la responsabilità del cambiamento, della critica e della trasformazione alla collettività.
Questo punto merita di essere sviluppato ulteriormente, concentrandosi sul rapporto tra amore e società.
Quale società è una società dell’amore?
Uno dei fili conduttori della riflessione che bell hooks propone è la tensione tra la ricerca di amore da parte di ogni persona e l’impossibilità di realizzarla nella società di oggi. L’autrice dipinge una gioventù che si dichiara cinica rispetto all’amore e che tuttavia ne ha bisogno, lo desidera, lo cerca. Questo cinismo è quindi in effetti solo un modo di nascondere la paura di mettersi in gioco e del dolore che causa il non ricevere amore. «I giovani d’oggi sono cinici, perché in fondo sono convinti che sia impossibile trovare l’amore» (p. 11).
La ragione per cui le nostre speranze sono tanto frustrate da indurci ad assumere un atteggiamento da scettic3 dell’amore non dipende da casi isolati, da singoli amori non corrisposti, ma è strutturale. La cultura di questa società tende a renderci incapaci di amare.
È una cultura, quella della società capitalista, in cui «il meccanismo dell’avidità è ormai diventato la norma» e quindi «la disumanizzazione diventa accettabile» (p. 93). L’amore diventa un oggetto, una merce che si può acquistare o di cui comunque si fruisce in modo consumistico. Si cerca la soddisfazione temporanea del desiderio individuale, ripetibile ogni qualvolta lo si voglia.
Nonostante possa sembrare che il discorso di bell hooks assuma qui tratti moralistici, la sua tesi va ben oltre il perbenismo ed è chiara: nel capitalismo non è possibile la realizzazione del concetto di amore, cioè l’amore come relazione.
Amare, volere bene, insiste l’autrice, significa sia sentirsi spronat3 dall’altra persona alla realizzazione personale di sé sia prendersi cura dell’altra persona, ovvero impegnarsi, a propria volta, per la sua realizzazione. Questo prendersi cura implica dunque una dimensione attiva. Come scrive bell hooks, l’amore è un’azione (p. 126), una scelta di agire per rendere possibile la realizzazione dell’altrə. “Ti voglio bene” non vuol dire semplicemente “ti auguro che le cose ti vadano bene” – un messaggio di speranza che non richiede impegno da parte nostra – ma significa attivarsi, supportare e aiutare la persona amata a creare le condizioni per la realizzazione di sé.
Tuttavia, come può prendere corpo questa relazione in una società che inibisce qualsiasi agire che non produca l’utile individuale e lasci quello altrui alla buona sorte? Una società che si limita a garantire la possibilità astratta che ognunə possa realizzarsi, senza poi provvedere alle condizioni materiali e culturali affinché questo accada?
Se da una parte è chiara la critica dell’autrice a una società che ostacola lo sviluppo dell’amore, sembra mancare la domanda sulle condizioni che invece renderebbero questa relazione possibile. Quali condizioni materiali, quali strutture sociali e quale educazione possono favorire la crescita di relazioni sane? Quale società ci permetterebbe di costruire legami di stima reciproca e sostegno nella realizzazione di sé e dell'altrə?
E d’altra parte, senza tali condizioni, la concezione di amore che l’autrice ci propone non rischia forse di diventare elitaria? Un amore accessibile a poch3? Tralasciando questi interrogativi, la proposta di bell hooks si concentra invece sull’altro lato del rapporto tra società e amore, cioè su come l’amore stesso possa essere forza creativa di una nuova società.
La costruzione di sane pratiche di amore, se condivisa e diffusa, contribuirebbe essa stessa a una diversa società. È per questo che bell hooks vede nell’amore un potere trasformativo: mettere in pratica l’amore può trasformare la società.
Questa potenzialità dell’amore fa da collante al più ampio progetto in cui All About Love (1999) si inserisce. Non va infatti dimenticato che il libro è parte di una trilogia insieme a Salvation: Black People and Love (2001) e Communion: The Female Search of Love (2002).
Il primo testo analizza la relazione della comunità afro-americana con l’amore, tra l’eredità della schiavitù e i movimenti di liberazione. Il secondo propone un’operazione simile ma considerando il rapporto delle donne con l’amore.
In queste ultime opere della trilogia si manifesta un aspetto già latente in All About Love: emancipare l’amore dalla sua narrazione tutta schiacciata sul “romanticismo” permette di ritrovarlo e riconoscerlo nelle pratiche di lotta e di costruzione di una dimensione comune. bell hooks critica il fatto che l’amore venga spesso squalificato nel discorso e nell’immaginario politico. Così facendo si resta ciech3 di fronte a tutte quelle forme di amore che invece sottendono e sostengono l’azione collettiva, che costruiscono comunità, educando alla responsabilità nei confronti sia dei singoli sia dei processi intersoggettivi.
L’amore come strumento di liberazione dalla paura
Concludiamo con un ultimo pensiero. Tra gli innumerevoli spunti di riflessione suscitati da questa lettura, uno in particolare ci ha permesso di “scendere a fondo” nei nostri vissuti personali: il tema della paura, nei vari modi in cui viene articolato da bell hooks.
Ci è parso, come è stato già precedentemente discusso in questo testo, che All About Love possa essere considerato come una ricetta dei sinonimi e contrari, dove riconoscere cosa “appartiene” all’amore, di che cosa questo si componga e che cosa escluda. Potrebbe apparire svantaggioso soffermarsi sui contrari piuttosto che sui sinonimi, ma a noi è sembrato un esercizio rivelatore.
«Quando amiamo, la paura inevitabilmente scompare» (p. 79): è una delle dichiarazioni necessarie a questo libro. Cosa ricerchiamo nel momento più buio, in cui le certezze crollano e la realtà si sgretola, se non l’amore? Quella dimensione che bell hooks più volte identifica come «paradiso dell’amore» (p. 5). E perché è così vero che l’amore può liberarci da ogni sconforto e affanno?
Principalmente perché è strumento di liberazione. Per quanto possa sembrare di inciampare in una “frase da Bacio Perugina”, questa definizione diventa reale in quanto opera di fatto nel contesto femminista. Nel tentativo delle strutture patriarcali di controllare il nostro sistema sociale, dall’assetto politico a quello più intimo familiare, la paura viene utilizzata come arma di controllo e strumento di dominazione: «La paura è il principale sostegno delle strutture di potere» (p. 79). Amaramente, l’esempio cardine può essere l’esercizio della violenza fisica e psicologica da parte di una persona abusante all’interno delle mura domestiche. E quanto insiste bell hooks nel sottolineare l’errata associazione secondo cui ciò che riceviamo nell’ambito della famiglia sarebbe necessariamente amore! È solo quando comprendiamo che paura e amore non possono sussistere nel medesimo spazio, «amore e maltrattamenti non possono coesistere» (p. 23), che realizziamo come l’amore sia l’unica via da percorrere per fuggire dalla spirale del terrore. Ed è per questo che ritroviamo una piena incarnazione dell’amore nel gesto femminista di aiuto e liberazione della persona che subisce oppressione e abusi.
La visione femminista viene in soccorso anche sul piano in cui la paura è stata interiorizzata a tal punto da dominare ogni nostra esperienza: il non sentirci adeguatamente “giust3” per ricevere amore. Uno dei primissimi pensieri che bell hooks condivide nella prefazione è il seguente: «fu invece il fatto di non averne abbastanza (amore) a farmi capire quanto sia importante» (p. 5), ed è da qui che bisogna partire. L’inadeguatezza che percepiamo, figlia della privazione che abbiamo sperimentato, è anche ciò che ci fa riconoscere quanto l’amore sia soggetto cardine delle nostre vite, portandoci ancora di più a “sentirne” la rumorosa assenza.
Mirando alla radice del problema, che cosa ci fa sentire inadatt3 all’amore e non meritevoli di riceverlo? bell hooks fa chiarezza sul punto (anche se non oseremmo affermare che il punto è risolto): sono le esperienze passate di abbandono, disamore e abuso che hanno viziato in noi questa sensazione. Raggiungere una simile consapevolezza, anche se non sostituisce un percorso di elaborazione personale ed eventualmente di psicoterapia, può darci sollievo. Non sembra però fornire soluzione allo status in cui ci troviamo. bell hooks ci suggerisce quindi di fare un passo in avanti, in accordo con la naturale prosecuzione della dimensione fisica del tempo, per cui, ad oggi, tornare indietro è impossibile. «Non si può tornare indietro. Adesso lo so. Si può solo andare avanti. Possiamo trovare l’amore a cui anela il nostro cuore, ma non prima di aver smesso di soffrire per l’amore che abbiamo perduto molto tempo fa» (p. 5).
Non è un’operazione facile quella proposta in queste righe: ci invita a non restare schiav3 di una “mancanza” e ci disillude rispetto al fatto di poterla colmare attraverso un’eterna rimuginazione. Il “ritorno” all’amore richiede un salto, un atto di volontà che investe sul presente e sul futuro.
Un libro da leggere?
Una domanda che ci siamo poste durante l’ultimo incontro di discussione collettiva è stata: consiglieremmo la lettura di questo libro? Sì, se si è dispost3 a lasciarsi guidare dalla scrittura di bell hooks e a sperimentare un cammino non lineare. Noi abbiamo dovuto mettere da parte le aspettative sulla base delle quali avevano scelto All About Love come oggetto di un seminario di ricerca. Ciò non significa, tuttavia, che il testo non sia stato “all’altezza”. Anzi, ci ha aiutate a porre in questione le stesse lenti teoriche con cui lo stavamo esaminando. È sempre potente quando un libro costringe lettori e lettrici a riposizionarsi rispetto a esso.
Abbiamo aperto questo scritto dicendo che speravamo di trovare fra le pagine di bell hooks argomenti che ci aiutassero a illuminare il rapporto tra violenza di genere e rappresentazioni dell’amore impiegate per sminuire o normalizzare la gravità dell’abuso. Sarebbe scorretto da parte nostra affermare che il libro non fornisce strumenti per imboccare questo percorso. La riflessione sul potere di una (buona) definizione dell’amore e lo scenario che si apre una volta considerato quest’ultimo come fenomeno sociale e come metodo etico da attuare contro l’oppressione sono alcuni degli ingredienti per rivoluzionare le nostre pratiche quotidiane. Per riorganizzarci come comunità.
Alla fine, alcune risposte il libro ce le ha date, con il beneficio di non essere risposte definitive, ma proposte aperte. Inviti a fare e pensare.
(1) In questo testo faremo riferimento alla seguente traduzione italiana: bell hooks, Tutto sull’amore, a cura di Maria Nadotti, trad. di Lucia Cornalba, Feltrinelli, Milano, 2003.






